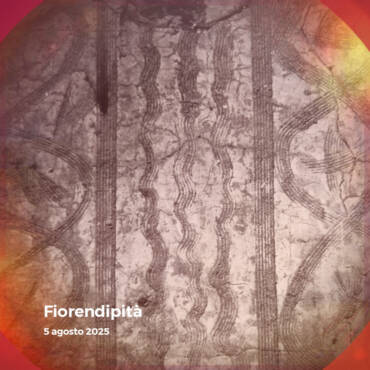Sant’Anna, avvocata della libertà. La Compatrona di Firenze e la sua festa – 26 luglio
Vi è un’immagine affrescata su una vela della volta nord-est nella chiesa di Orsanmichele che raffigura Sant’Anna, mentre sostiene un modellino sintetico – la rappresentazione simbolica ideale – della città di Firenze. È un’iconografia di matrice medievale, comune ai santi patroni di città o di fondazioni religiose. Ma perché mai Sant’Anna è raffigurata, in quello che viene definito da Giovanni Villani uno degli edifici più importanti del Trecento, quale patrona di Firenze?
Tutto ebbe inizio il 26 luglio 1343 – giorno di Sant’Anna – con la cacciata da Firenze del tiranno Gualtieri VI di Brienne- Duca d’Atene, per la sollevazione popolare dei «franchi cittadini con armata mano» (Villani), fatto che venne percepito dall’animo profondamente religioso dei contemporanei, quale signum caeli- il riconoscimento celeste della valenza sacra di un avvenimento prettamente politico. Il 26 luglio venne proclamato festa solenne e, come testimonia Giovanni Villani, «[…]s’ordinò per lo Comune, che la festa di Santa Anna si guardasse come Pasqua sempre in Firenze, e si celebrasse solenne ufficio e grande offerta per lo Comune e tutte l’arti di Firenze», poiché veniva sancita la liberazione dalla tirannia dello ‘straniero’ quale Resurrezione della Firenze Repubblicana.
Gli onori a Sant’Anna, madre della Vergine Madre di Dio, ora protettrice della città gigliata – appellata «Santa Avvocata della libertà cittadina», assunsero un valore sia religioso che civico e vennero tributati con un corteo solenne da parte del popolo fiorentino, insieme ai rappresentanti di tutte le Arti, di fronte alla miracolosa imago della Madonna delle Grazie presso l’Oratorio dell’Orto di San Michele.
La Loggia-Oratorio, a quel tempo anche granaio pubblico, innalzato e finanziato dalle Arti stesse, divenne così il fulcro delle celebrazioni della nuova compatrona di Firenze. Le si dedicò un altare ligneo (posto a sinistra del tabernacolo) e tutte le corporazioni delle Arti si recavano annualmente in pompa magna ad offrire dei ceri, ad appendere le proprie bandiere, targhe e vessilli sopra i pilastri tutto’attorno all’Oratorio e si correva un palio in onore della Santa, esattamente come accadeva per la festa del patrono San Giovanni Battista.
«Sant’Anna non sarebbe venerata nell’Oratorio di Orsanmichele se non per la cacciata del Duca d’Atene», osserva puntualmente la dott.ssa Anita Valentini – la ricercatrice a cui dobbiamo lo studio approfondito e il recupero di questa ed altre importanti tradizioni religiose e popolari fiorentine (vedi Bibliografia). E potremmo aggiungere che, molto probabilmente, anche la chiesa di San Carlo dei Lombardi, ad esso prospiciente, non esisterebbe.
Nel 1349, infatti, i Priori della Signoria decisero l’edificazione di una nuova cappella di Sant’Anna, separata dall’antica Loggia del grano. Il Comune designò per la scelta del luogo più adatto una squadra di periti, fra cui Neri di Fioravanti, Francesco Talenti, Benci di Cione Dami, gli stessi architetti della nuova loggia di Orsanmichele, la cui ricostruzione era iniziata già nel 1336. Fu suggerito l’acquisto e la demolizione di alcune case dei Galigari nella piazza dell’Orto di San Michele, proprio di fronte alla Loggia. Il terreno fu acquistato a spese del Comune, mentre l’edificazione della cappella doveva essere finanziata con le cospicue donazioni fatte alla Compagnia di Orsanmichele dopo la peste del 1348 e, successivamente, con parte delle offerte fatte il giorno di Sant’Anna in Orsanmichele. I primi capomastri della fabbrica furono proprio Neri di Fioravanti e Benci di Cione.
Tuttavia, già nel 1351 il progetto fu sospeso e gli architetti chiamati ad erigere bastioni e fortificazioni per l’esercito fiorentino in lotta contro gli Ubaldini. Ma è anche probabile che il motivo della sospensione dei lavori sia stato il malcontento dei Capitani di Orsanmichele, che oltre a vedersi defraudati del loro privilegio di gestire tutto quanto concerneva il prestigioso culto di Sant’Anna, si vedessero costretti comunque a contribuire alle spese per la nuova cappella che era posta però sotto la tutela dell’Arte di Por Santa Maria.
Nel 1354 la Signoria cambiò nuovamente idea e scelse di edificare la nuova chiesa intitolata a Sant’Anna fuori Porta San Frediano, presso il Monastero femminile benedettino di Sant’Anna in Verzaia (sorto nel 1318). E così, a partire dal 1370, la processione annuale per il 26 luglio si sarebbe snodata ‘di qua e di là d’Arno’ – fra Orsanmichele e il Monastero di Verzaia.
Di questa processione durante la festa di Sant’Anna abbiamo una vivace rappresentazione nella pala d’altare raffigurante la Vergine col Bambino e Sant’Anna con i Santi Sebastiano, Filippo, Pietro e Benedetto dipinta dal Pontormo, (1528-29, oggi al Museo del Louvre) e commissionata per l’altare maggiore della chiesa del Monastero benedettino di Verzaia, proprio dai Capitani – membri della Signoria che per tradizione vi prendevano parte.
Nel frattempo, la Compagnia dei Laudesi di Orsanmichele era riuscita a sostituirsi, per conto della Signoria, alla direzione della nuova fabbrica prospiciente il loro Oratorio, che dal 1379 in poi, proseguì su disegno di Simone di Francesco Talenti. Una volta terminata la costruzione nel 1404, fu dedicata all’Arcangelo Michele, in modo da conservare l’altare votivo e il culto connesso a Sant’Anna presso Orsanmichele.
Il nuovo culto a Sant’Anna, celebrato proprio a Orsanmichele, aveva contribuito ad accelerare e consolidare il passaggio da Loggia del grano a Oratorio. Nel 1359 era stato terminato il maestoso tabernacolo marmoreo dell’Orcagna – prezioso custode della tavola miracolosa della Madonna delle Grazie ad opera di Bernardo Daddi (1347). Da quel momento in poi, nei decenni a seguire, il Mercato del grano verrà spostato in una nuova sede (dietro Palazzo Vecchio – oggi Piazza del Grano), gli archi della Loggia progressivamente chiusi e la chiesa riccamente affrescata.
In una legge del 1461 la chiesa di Orsanmichele è ancora citata ufficialmente con il nome “Oratorio di Sant’Anna di fronte a san Michele”, mentre con il riferimento al templum dicti Sancti Michaelis, si intendeva la chiesetta della Confraternita dall’altra parte della strada. Nel 1616 il patronato della chiesa di san Michele passò alla confraternita della “Nazione Lombarda” che dedicò l’edificio a San Carlo Borromeo (canonizzato nel 1610), d’ora in poi San Carlo dei Lombardi.
Il fatto che le chiese di Orsanmichele e di san Carlo, siano state edificate negli stessi decenni, ad opera degli stessi architetti e gestite dalla stessa Compagnia dei Laudesi, ha contribuito ad alimentare presso i ricercatori l’ipotesi che possa esserci stato un collegamento sotterraneo fra i due edifici. Non mancano ricerche e pubblicazioni sui sotterranei di Firenze: segreti passaggi, cunicoli e gallerie che, in alternativa alle vie di comunicazione ufficiali, permettevano di spostarsi con discrezione e riservatezza- per comodità, ma soprattutto per sicurezza: sia per sfuggire ai nemici di turno, sia per la proverbiale conflittualità fra i cittadini stessi di Firenze. È perfettamente plausibile che si sia voluto realizzare un utile passaggio sotterraneo a collegamento fra le due chiese sotto via de’ Calzaiuoli, già all’epoca una delle più trafficate di Firenze, tuttavia attualmente non vi sono evidenze tangibili a riguardo.
Per tornare al nostro argomento principe, a questo punto non possiamo che domandarci:
Come è possibile che si sia arrivati alla dimenticanza di una festività così sentita ed importante per la cittadinanza?
Le circostanze che determinarono il progressivo ridimensionamento della valenza civica del patronato di Sant’Anna riguardano il suo utilizzo simbolico a partire dal 1494 da parte dei repubblicani in chiave antimedicea – con l’assimilazione della famiglia dei Medici al tirannico Duca d’Atene. Con il ritorno dei Medici a Firenze e la loro consacrazione a Duchi (1531) e poi Granduchi di Toscana (1569), il culto di Sant’Anna si svuotò progressivamente della sua valenza civica e politica, per ritornare ad essere, complice anche la Controriforma, prettamente devozionale – quale madre della Theotokos.
L’unico segno tangibile lungo i secoli, riferito anche da Robert Davidsohn, rimase l’usanza di esporre i vessilli delle Arti cittadine fuori della chiesa di Orsanmichele – traccia superstite degli antichi festeggiamenti in onore della Santa che perdura fino ai nostri giorni.
Bartola Sinibaldi
Iconografa e Ceramografa
Bibliografia e sitografia
Banchi Barbara (a cura di), Il Palagio dell’Arte della Lana: dalle origini ad oggi. The Wool Guild Palace: since its origins, Firenze, Società Dantesca Italiana, 2009.
Castellazzi Giuseppe, Il palazzo detto di Or San Michele: i suoi tempi ed il progetto del suo restauro, Roma, Tipografia Fratelli Bencini, 1883.
Davidsohn Robert, Storia di Firenze, Firenze, Sansoni, voll. 8.
Finiello Zervas Diane (a cura di), Orsanmichele a Firenze, Modena, F. C. Panini, 1996.
Pagni Mario, Pecchioni Lorenzo, I templari di Firenze, storia e archeologia del tempio fiorentino, Documentario DVD, 2010
Pecchioni Lorenzo, Riflessioni su Orsanmichele. Una continuità cultuale dagli Etruschi al Rinascimento, Fiorendipità (blog).
Pecchioni Lorenzo, I “sotterranei del cielo” a Firenze, Fiorendipità (blog).
Valentini Anita, L’iconografia fiorentina di Sant’Anna: la festa del 26 luglio, Rotary Club Bisenzio, 1998.
Valentini Anita (a cura di), Sant’Anna dei fiorentini: storia, fede, arte, tradizione, Firenze, Polistampa 2003.
Valentini Anita, Cantuti Castelvetri Maria Giulia, Florentine Festivals from the Middle Ages to the Modern Age and Their relationship with Art, Cambridge Scholars Publishing, 2024.
Villani Giovanni, Cronaca, ante 1348.